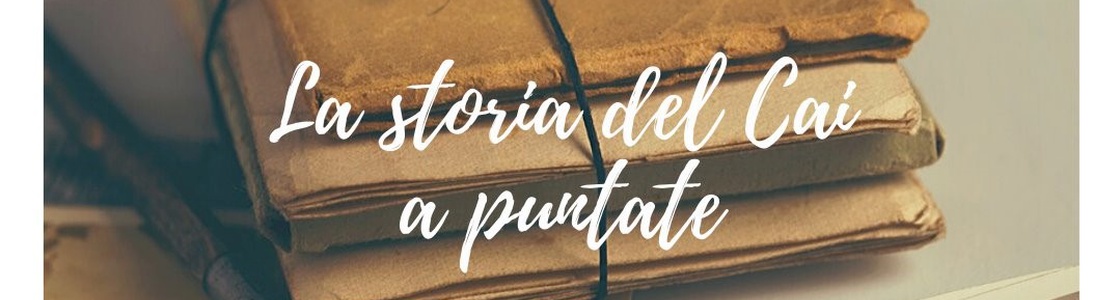
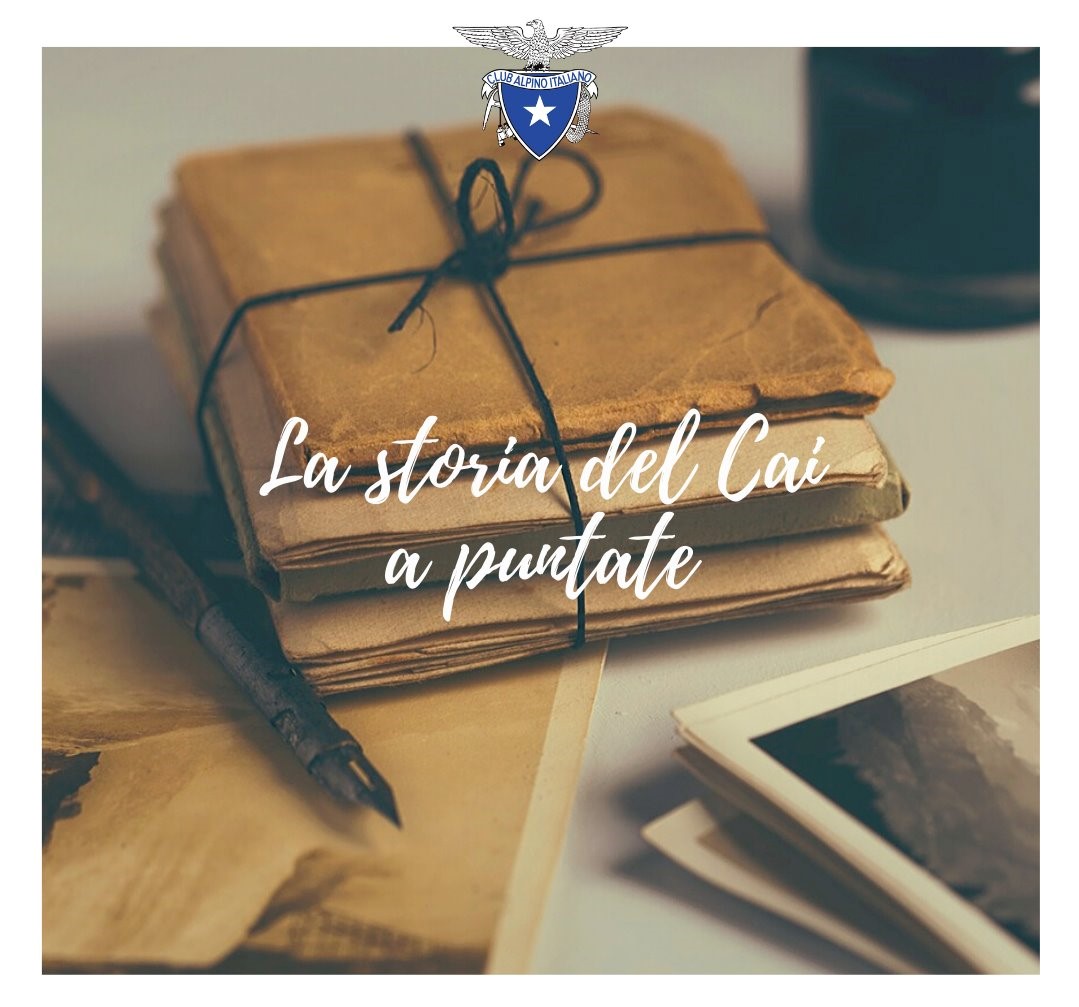
Storia del Cai a puntate, gli anni sessanta e la contestazione dell'artificialismo
di Club Alpino Italiano
Un altro decennio di storia del sodalizio, raccontato da Roberto Mantovani. Una decade di cambiamenti anche per l'arrampicata, dove si chiede maggiore attenzione alla modalità con cui viene compiuta questa attività
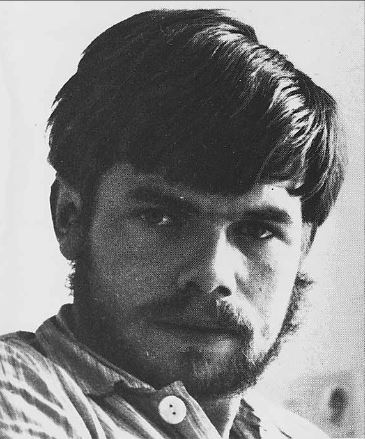
Gli anni Sessanta sono stati un periodo di grandi trasformazioni. "Eravamo tutti nella stessa barca: una barca che andava alla scoperta del Nuovo Mondo", raccontava John Lennon. Anche per l'alpinismo è stato un periodo di cambiamenti, in cui nasce la contestazione dell'artificialismo e guadagna più spazio l'attenzione per la modalità dell'arrampicata. Racconta questo periodo Roberto Mantovani:
"Anni di transizione? Il massimo delle aberrazioni dell’arrampicata artificiale? La rinascita della libera? Il decennio 1963–1973 è un periodo che, iniziato con i festeggiamenti per il centenario della nascita del Club Alpino, dal punto di vista alpinistico contiene tutto e il contrario di tutto. Accoglie idee contrastanti, che per un po’ convivono per poi entrare in aperto conflitto. Ci sono pure discussioni e polemiche. Grandi scalate invernali. Personaggi vecchi e nuovi di diverso orientamento. E infine appaiono tendenze inedite che daranno luogo alla rivoluzione del decennio successivo.
Ma andiamo con ordine. Cominciamo dal centenario del Cai, che viene celebrato ovunque e produce interessanti pubblicazioni che indagano il passato. Da menzionare, perché va a scavare tra le scartoffie della prima sede del sodalizio, l’annuario della sezione di Torino, Scàndere 1963, firmato da Armando Biancardi, che si limita però alle vicende dei torinesi.
Dicevamo poi dell’alpinismo invernale. Gli anni ’60 raccolgono il testimone del decennio precedente e inanellano imprese di altissimo livello. Se nel 1962 Giorgio Redaelli, Roberto Sorgato e Giorgio Ronchi si sono distinti per la prima invernale della Su Alto, il 1963 è l’anno di altre due grandi invernali, quella della Solleder alla Civetta, ad opera di Ignazio Piussi, Giorgio Redaelli e Toni Hiebeler, e quella dello Sperone Walker delle Grandes Jorasses, che reca la firma di Walter Bonatti e Cosimo Zappelli. E presto ce ne saranno altre, tutte di prestigio: lo Spigolo Cassin alla Torre Trieste nel 1964 (Aldo Anghileri, Andrea Cattaneo, Pino Negri e Ermenegildo Arcelli), il Pilier Gervasutti al Mont Blan du Tacul nel 1965 (Corradino Rabbi e Gianni Ribaldone), e la via nuova, in solitaria invernale, di Walter Bonatti sulla parete nord del Cervino, l’ultima scalata estrema dello scalatore lombardo prima del suo ritiro dall’alpinismo sportivo. E poi altre ancora, che non riusciamo a citare per mancanza di spazio. Anche se non possiamo dimenticare nel 1967 le prime invernali dello spigolo nord dell’Agner (Heinrich e Reinhold Messner e Sepp Mayerl), della Solleder alla Furchetta (Heinrich e Reinhold Messner e Heini Holzer), della Cassin al Pizzo Badile nel 1967-’68 (Paolo Armando, Gianni Calcagno, Alessandro Gogna, Michel Darbellay, Camille Bournissen e Daniel Troillet), oltre agli exploit dei fratelli Antonio e Gianni Rusconi, da soli o con compagni diversi, tra il 1968 e i primi anni ’70 (vie nuove al Badile, al Cengalo e alla nord ovest della Civetta; via Piussi-Redaelli alla Torre Trieste; via delle Guide al Crozzon di Brenta).
D’estate, nel solco della tradizione, mentre ancora primeggiano Walter Bonatti e Cesare Maestri, consolidano il loro ruolo Armando Aste, autore di autentici capolavori nelle Dolomiti (basti pensare alla sua via dell’Ideale sulla sud della Marmolada), e poi ragazzi più giovani. Tra questi Alessandro Gogna, che inanella una serie di scalate che lasciano il segno, spesso con compagni del livello di Leo Cerruti, Alberto Dorigatti, Almo Giambisi, Bruno Allemand. Ma sono assai attivi anche Giorgio Bertone, i fratelli Squinobal, Guido Machetto e Gianni Calcagno. E soprattutto il triestino Enzo Cozzolino, vero talento dell’arrampicata e dell’alpinismo dolomitico. A lui si devono l’apertura del favoloso diedro sul Piccolo Mangart di Coritenza nelle Giulie, vie nuove e solitarie in Dolomiti, e poi la mitica via dei Fachiri sulla parete sud ovest di Cima Scotoni. Peccato che la carriera del “Grongo” duri troppo poco: Cozzolino muore ai piedi della Torre di Babele, in Civetta, il 18 giugno 1972. Infine, ma certo non per ultimo, va ricordato Reinhold Messner che nei primi anni ’60 ha già un curriculum incredibile.
Poi – lo abbiamo annunciato all’inizio – c’è la questione dell’artificialismo. Abbiamo già fatto cenno alle aberrazioni e alle chiodature esagerate. Accanto ad artificialisti che usano tutto il bagaglio tecnico tradizionale e la loro abilità prima di forare la roccia, spuntano arrampicatori che non si fanno scrupoli a disseminare pilastri e pareti di chiodi a espansione. Il punto di non ritorno si registra nella seconda metà del decennio, nella estrema parte sinistra della parete nord della Cima Grande di Lavaredo e sulla parete sud della Torre Trieste. Ma, come sempre, il troppo stroppia. Vie illogiche, aperte a furia di chiodi a espansione generano una reazione a catena, accompagnata da critiche e polemiche. E presto si arriva al rigetto e alla contestazione, che riporta in auge la tradizione dell’arrampicata libera.
Sul numero 10/1968 della “Rivista Mensile”, Reinhold Messner, che ormai si è già fatto ampiamente un nome in Dolomiti, tuona contro quello che lui chiama “L’assassinio dell’impossibile”. «Le pareti non vengono più vinte in arrampicata» constata il giovane Reinhold, «bensì umiliate con un lavoro manuale e metodico, una lunghezza di corda dopo l’altra (...)». E prosegue: «Non è più il coraggio, bensì la tecnica il fattore decisivo». E ancora: «Un tempo, la storia dell’alpinismo si scriveva sulle muraglie di roccia con la penna simbolica dell’ardimento; oggi, si scrive con i chiodi. (...) L’impossibile è sgominato, il drago è morto avvelenato e l’eroe Sigfrido è disoccupato. Ognuno si lavora la parete piegandola con il ferro alle proprie possibilità. Io mi preoccupo per il drago ucciso: dobbiamo fare qualcosa prima che l’impossibile venga sotterrato. (...) e, in avvenire, proseguiamo sulla strada indicataci dagli uomini del passato: io sono convinto che sia ancora quella giusta! (...) Se hai un compagno, porta con te la corda ed un paio di chiodi per i punti di sosta, ma nulla di più».
Così Reinhold Messner, che l’estate precedente, in cordata con il fratello Günther ha salito il Pilastro di Mezzo del Sass dla Crusc, in Val Badia, e ha superato un passaggio superiore al VII+, anche se in quel momento la scala delle difficoltà è ancora bloccata al VI. Reinhold, però, non è l’unico a pensarla così in fatto di arrampicata libera, e le sue idee mettono radici".







