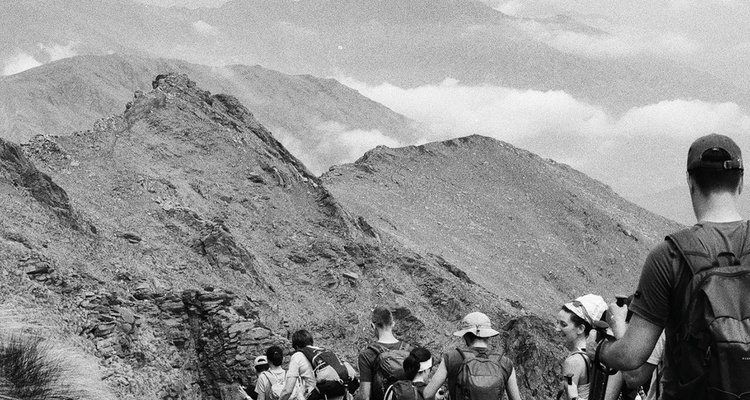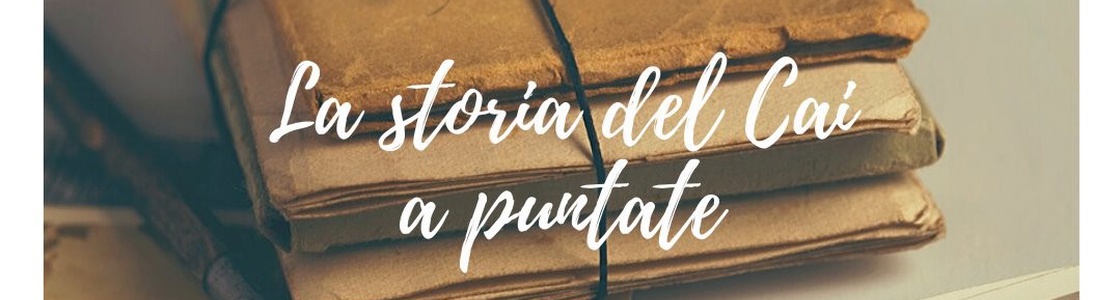
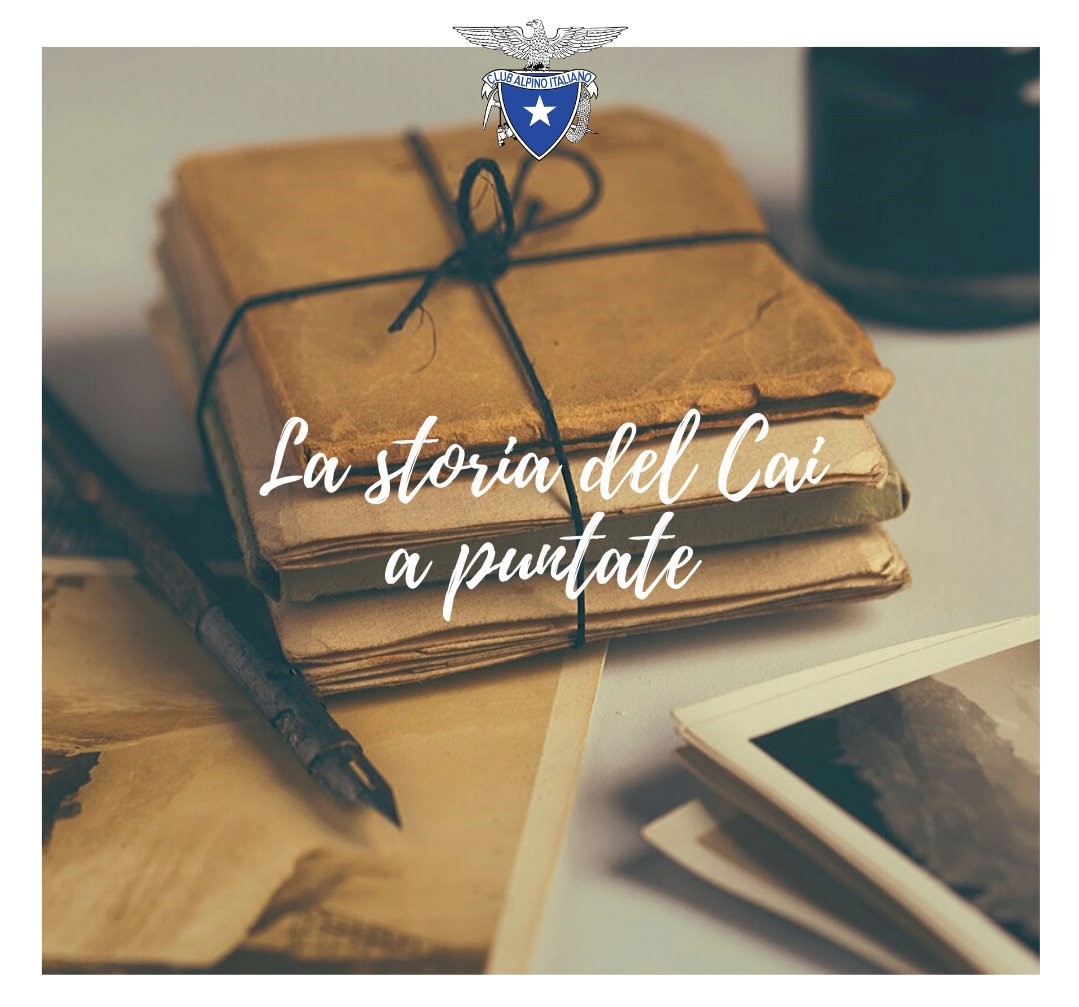
Storia del Cai a puntate, anni rivoluzionari
di Club Alpino Italiano
I Settanta e gli Ottanta portano in dono all'alpinismo inedite riflessioni e tante novità. Ci racconta questo periodo Roberto Mantovani
Sono anni di grande trasformazioni quelli a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta. Tante le strade che si aprono nell'alpinismo di fine secolo, a partire dalle nuove raffinate riflessioni di Gian Piero Motti. Ci parla di questo periodo Roberto Mantovani:
"Il periodo che va dal 1974 al 1983 è un’esplosione di nuove realizzazioni, di idee innovative, di sperimentazioni, di tempi di percorrenza che lasciano tutti a bocca aperta. I vecchi limiti vengono polverizzati, la gabbia del VI grado finalmente si apre e la ruota della storia dell’alpinismo comincia a girare a una velocità sconosciuta fino a quel momento.
Sul numero di aprile del 1974 della «Rivista della Montagna» Gian Piero Motti, ben noto per i suoi articoli anche ai lettori della «Rivista» del Cai, pubblica uno scritto che presto diventerà il manifesto di un nuovo modo di avvicinare la roccia. Si intitola: Il Nuovo Mattino. Analisi dell’alpinismo californiano. Il tono dell’autore è pacato e oggettivo. Ma ha la forza di un uragano e, nel mondo dell’arrampicata, viene percepito come il punto d’innesco di una vera e propria rivoluzione. Gian Piero racconta delle grandi pareti di Yosemite, parla di nut, peck, copperheads, cliff hanger, rurp. Ma anche di vita in parete, di arrampicata come strumento di introspezione, di capacità visionaria, di una possibile alternativa all’alpinismo europeo «di derivazione romantica e idealistica».
In altri articoli, Motti cita poi nuove vie aperte sulle pareti di gneiss nella Valle dell’Orco: Tempi Moderni, Sole nascente, Cannabis, Il lungo cammino dei Comanches. Itinerari lungo i quali – spiega – è possibile vivere lo stesso “istante” che si può sperimentare sul Petit Dru o sulla Civetta. Vie il cui lo scopo non è raggiungere la vetta e nemmeno affermare sé stessi. Lassù – dice – l’arrampicata si trasforma soprattutto in «un mezzo per vivere sensazioni più profonde».
Una strada diversa, un nuovo modo di vivere l’alpinismo. Purtroppo Gian Piero morirà prematuramente nel giugno 1983. Anche nel resto dell’arco alpino c’è una forte agitazione.
Sono comparse da poco le prime scarpette da arrampicata a suola liscia e le protezioni mobili. Nelle valli della provincia di Sondrio i Sassisti inventano vie difficili su fantastiche placche di granito. Ma parlano delle loro scalate in maniera insolita. Rivendicano la necessità della “pace con l’alpe”, in contrapposizione a quell’alpinismo eroico riassunto nel vecchio motto di Guido Rey stampigliato sulle tessere del sodalizio.
Seguendo un binario parallelo ma profondamente diverso, nel 1977, in Val di Mello, due giovani arrampicatori milanesi – Ivan Guerini e Mario Villa – tracciano una difficilissima via di salita sul Precipizio degli Asteroidi. Nell’occasione, discettano senza falsi pudori di VII grado. Ma non sono i soli a rivendicare quella che, date le regole del periodo, sembra un’eresia.
Anche Renato Casarotto, in Dolomiti, parla in quei mesi difficoltà di VII grado. Spiega di averle superate, con Bruno De Donà, sul Diedro Sud dello Spiz di Lagunaz, nelle Pale di San Lucano. Ci vorrà però ancora un anno prima che l’UIAA, durante il congresso di Lagonissi, in Grecia, ufficializzi l’entrata in vigore del settimo grado (la scala UIAA tuttavia verrà definitivamente aperta verso l’alto solo nel 1985). Ma siamo solo agli inizi. In quegli stessi anni, la tranquillità dei Monti Pallidi viene messa a dura prova da una ridda di notizie che lasciano senza parole i tradizionalisti. Oltre che le invernali e le solitarie di Renato Casarotto, che scuotono dalle fondamenta l’intera regione dolomitica, sono le scalate di un gruppetto di giovani arrampicatori italiani e austriaci a lasciare tutti a bocca aperta. Si tratta di Heinz Mariacher, Luisa Iovane, Luggi Rieser, Reinhard Schiestl, Roberto Bassi, Maurizio “Manolo” Zanolla, Bruno Pederiva, Alberto Campanile, Pierluigi Bini, Franco Perlotto, Giancarlo Milan, Ben Laritti, e altri ancora.
Sono gli anni della prima salita in libera della via Messner al Sass dla Crusc, dell’apertura di Don Quixote, di Vogelwild, di Abrakadabra, di Sancho Panza, di Moderne Zeiten, della prima ripetizione della viaAttraverso il Pesce sulla Sud della Marmolada. Un’abbuffata di vie che per Manolo, Mariacher e Bassi continuerà poi più in basso, sulla roccia di Arco e della Valle del Sarca. Manolo ha cominciato ad arrampicare tra la fine dei ’70 e l’inizio degli ’80. È giovane, ha fatto esperienza sulle Prealpi bellunesi e sulle Pale di San Martino. Poi ha ripetuto in libera numerose grandi classiche dolomitiche e ha sperimentato i suoi limiti in falesia, dove ha raggiunto difficoltà davvero estreme. Sul Totoga, la “sua” falesia privata, nel 1981 traccia Il mattino dei maghi (IX-, 7c+). Il massimo delle difficoltà, in quel periodo. E non bisogna dimenticare che in Dolomiti, sulla Est del Sass Maor, un anno prima ha aperto Supermatita (VII obbligatorio, con soli sette chiodi su 1000 metri di parete) con Pietro Valmassoi. Una via che ha lasciato tutti senza parole.
Tra le grandi invernali del decennio va ricordata l’attività dei fratelli Rusconi, già citati lo scorso numero, e poi l’incredibile attività di Renato Casarotto: marzo 1974, prima invernale dello Spigolo Strobel alla Rocchetta Alta di Bosconero (con Pierino Radin e Diego Campi); dicembre 1974: prima invernale solitaria della via Simon-Rossisulla nord del Pelmo; febbraio 1975: prima invernale solitaria della via Andrich-Faè sulla Punta Civetta; 1-15 febbraio 1982: Trittico invernale del Frêney al Monte Bianco, in solitaria: un’impresa da Titani!; 30 dicembre 1982 – 9 gennaio 1983: prima invernale del Diedro Cozzolino al Piccolo Mangart di Coritenza.
La sintesi di quegli anni mitici è però ancora troppo parziale. C’è molto da raccontare, ed è facile che qualcosa di importante resti fuori da queste pagine. Grandi scuse, quindi, ma lo spazio è tiranno.
A questo punto bisogna dire dell’arrampicata sul ghiaccio. E dobbiamo parlare di un’altra rivoluzione. Quella della piolet traction. Sono state le montagne scozzesi a fare da incubatore al cambiamento. Sulle Alpi i primi attrezzi adatti all’ancoraggio su ghiaccio compaiono nei primi anni ’70. Nel 1973 due guide francesi, Walter Cecchinel e Claude Jager, vincono in tre giorni l’orrido couloir (orientato a nord est) tra il Grand e il Petit Dru. In breve, la piolet traction fa schiere di proseliti. In Francia si impongono Jean-Marc Boivin e Patrick Gabarrou. In Italia il meglio è rappresentato dalla cordata Gianni Comino – Gian Carlo Grassi (l’ordine è puramente alfabetico). Il 18 luglio 1978, assieme a Renato Casarotto, i due alpinisti tracciano un’incredibile via nuova sulla nord dell’Aiguille Verte. Poi, il 20 agosto, Grassi e Comino superano l’Ypercouloir del versante sud delle Grandes Jorasses, che presenta tratti con cascate verticali e persino strapiombanti.
Nell’estate del 1979, Gianni e Gian Carlo realizzano altri due exploit fuori misura: sul seracco del Col Maudit e sul seracco di sinistra della Poire, al Monte Bianco. Scalate da marziani. Poi, il 28 febbraio 1980, Comino affronta da solo lo spaventoso colatoio tra gli speroni della Major e della Poire, sul versante Brenva del monte Bianco. Vicino all’uscita, una scarica di ghiaccio lo trascina a valle. Solo un anno prima, il 1979, l’alpinismo aveva inventato un nuovo terreno di gioco invernale. Le cascate gelate.
Tra i pionieri dell’inedito gioco nel «giardino di cristallo», Gian Carlo Grassi, Gianni Comino e una piccola schiera di appassionati. Sarebbe stato l’inizio di una lunga vicenda. Presto però comincerà a srotolarsi anche un’altra storia, quella del bouldering. Un’attività che sul momento non ha ancora un nome specifico. Arrampicare sui blocchi di roccia è un gioco vecchio come l’alpinismo, ma con la modernità diventerà un’attività a se stante. Grosse novità arrivano infine dalle montagne lontane.
Nel 1975 una spedizione nazionale guidata da Riccardo Cassin tenta l’indomabile parete sud del Lhotse. Ne fa parte la crème dell’alpinismo nazionale. Poco dopo, l’himalaysmo cambia marcia. Comincia l’era dello “stile alpino”. Nel 1975 Gianni Calacagno e Guido Machetto aprono la via degli italiani sul Tirich Mir (7708 m), in Hindukush. E Reinhold Messner e Peter Habeler salgono una via nuova, anche questa “all’alpina”, sul versante nord dell’Hidden Peak, in Karakorum. Poi, nel 1977, in 17 giorni, Renato Casarotto supera in solitaria la tremenda parete nord del Huascaran Norte, in Perù. Una performance straordinaria.
L’anno dopo, l’8 maggio, Messner e Habeler giungono in vetta all’Everest senza far uso dell’ossigeno. E tre mesi più tardi Messner sale il Nanga Parbat dal versante Diamir, portando a termine la prima solitaria in stile alpino di un 8000. Nel 1979 Casarotto sale in prima ascensione solitaria il pilastro nord est del Fitz Roy e prosegue fino alla cima principale. Poi la palla ripassa nelle mani di Messner, che nel 1980 sale l’Everest, da solo e in stile alpino, dal versante settentrionale. E ancora, nel 1983, va citata la prima ascensione di Casarotto, in solitaria, sullo sperone nord del Broad Peak Nord (7600 m). Dimentichiamo qualcosa? Senz’altro. Ma attenzione: andrà peggio nei dieci anni a venire, perché l’alpinismo corre ormai a una velocità assai superiore rispetto al passato".