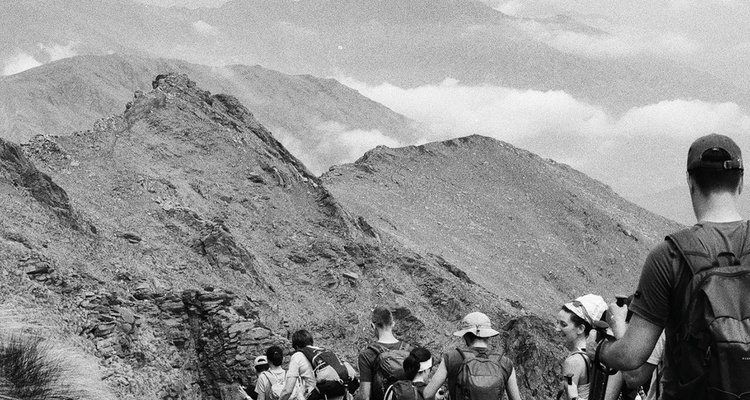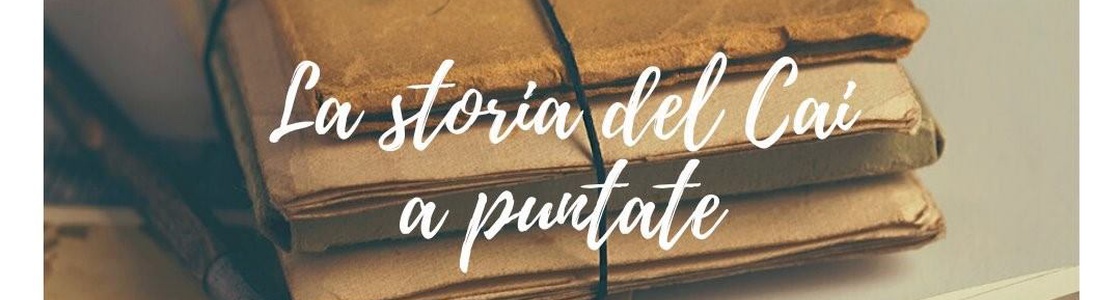

Storia del Cai a puntate, un decennio di grandi imprese
di Club Alpino Italiano
Dopo la conquista del K2 gli anni cinquanta proseguono con la spedizione sul Gasherbrum IV. Giulio Giorello e Luca Guzzardi ci parlano di questo decennio.
Dopo il K2 arriva l'impresa del Gasherbrum IV. Continua il viaggio nella storia del Club alpino italiano. Questa puntata è stata firmata da Giulio Giorello e Luca Guzzardi.
"Estate 1958, Campo VI – quota 7550 metri – sotto la sommità del Gasherbrum IV, “il bellissimo picco” che sfiora gli Ottomila: “Lassù in alto, sulla cresta, il 6 agosto s’è levato tra sanguinose fasce di luce, e foschie verso oriente, che non promettono nulla di buono. Ma ormai tutto è pronto: sarebbe follia rimandare. Oggi è senza discussioni la giornata della vetta”. Questo il ricordo che Walter Bonatti serba di quella mattina, poco prima di partire con il compagno Carlo Mauri alla conquista di una cima (dalla cresta nord-est) fino ad allora ritenuta dai più inaccessibile. I problemi non sono pochi: 'Le difficoltà tecniche si aggirano attorno al quinto grado; inoltre la quota, il gelo e la bufera prossima a infuriare rendono esasperante la progressione. È una lotta veramente disperata la nostra fra la realtà e noi stessi, ma alla fine siamo noi a vincere e alle 12,30 esatte le nostre bandierine d’Italia, del Pakistan e del CAI sventolano o meglio sbattono al vento burrascoso della vetta [7925 metri]. Idealmente tutta la spedizione è con noi quassù a vivere questo fatidico momento. Ci abbracciammo commossi'.

Il successo aveva richiesto cinquecento portatori per oltre sette tonnellate di materiale, due assalti alla vetta (separati da quasi un mese di maltempo, trascorso al Campo Base) in due tentativi ciascuno, l’approntamento di sei Campi in quota. Quattro anni prima, il trionfo sul K2 a opera di Compagnoni e Lacedelli, sotto la direzione di Ardito Desio e con il contributo determinante di Bonatti, aveva suggellato l’attività internazionale del CAI del decennio “di svolta” 1944-1953 (come ha scritto Franco de Battaglia nello scorso numero di Montagne360); ma è l’ambiziosa spedizione al Gasherbrum IV a rappresentare l’icona dei dieci anni successivi.
Organizzata da Riccardo Cassin, l’impresa conta tra i suoi membri, oltre a Bonatti e Mauri, Bepi de Francesch, Toni Gobbi, Giuseppe Oberto, il medico Donato Zeni e l’orientalista Fosco Maraini, interprete e fotografo del gruppo, nonché autore della relazione di viaggio grazie anche ad appunti e memorie dei compagni (Gasherbrum 4°. Baltoro, Karakorum, Leonardo da Vinci, Bari 1959; poi ripubblicata come Gasherbrum IV. La splendida cima, Vivalda, Torino 1996 e successive ristampe). Lui stesso alpinista di alto livello – membro del Club Alpino Accademico, aveva cominciato la sua attività di scalatore nelle Dolomiti con Emilio Comici, Tita Piaz, Sandro del Torso –, Maraini è pure ottimo conoscitore dell’universo himalayano, che aveva esplorato nel corso di due spedizioni in Tibet (1937 e 1946) con il grande tibetologo Giuseppe Tucci. Un anno dopo l’ascesa del Gasherbrum IV tocca a lui dirigere una spedizione.
Questa volta la meta è nello Hindu-Kush, la più occidentale (fra Pakistan e Afghanistan) delle grandi catene che si dipartono dal Pamir. Si tratta del Picco Saraghrar (7349 metri), la vetta più alta del massiccio omonimo, raggiunta il 24 agosto 1959 da due cordate, formate da Paolo Consiglio e Franco Alletto la prima, da Giancarlo Castelli e Carlo Alberto Pinelli la seconda. Quest’ultima spedizione, organizzata dalla sezione romana del CAI, ha una più marcata connotazione esplorativa in confronto a quella nazionale al Gasherbrum, dove era prevalente l’aspetto di sfida alpinistica.
C’è, però, un’altra differenza rilevante fra le due imprese, che è stata colta magistralmente dallo stesso Maraini nella cronaca di quell’avventura (Paropàmiso, Leonardo da Vinci, Bari 1963; ora Mondadori, Milano 2003) ed esprime due volti del CAI, cioè due approcci all’alpinismo, i quali, lungi dall’essere in competizione, si integrano l’uno coll’altro: 'A differenza della spedizione del Gasherbrum, composta [...] dai migliori professionisti italiani della montagna di quel periodo, la spedizione al Saraghrar era composta da cittadini amatori della montagna, e provenienti da varie professioni'.
All’alpinismo come professione animata da una passione che spinge a sfide estreme sotto il profilo fisico e psicologico si coniuga l’alpinismo come esplorazione e oltrepassamento dei confini che delimitano il proprio mondo. Quest’ultima è una 'lotta' non meno difficile di quella contro i limiti fisici. Si tratta, infatti, di una spregiudicata sfida a sè stessi per superare tutti quei vincoli culturali che ci tengono legati alla nostra 'ovvia' visione del mondo, in modo da acquisire invece un orizzonte più ampio, constatando quella che da più parti è stata chiamata la mobilità del filo dell’orizzonte.
'I viaggi possibili sul pianeta Terra – continuava Maraini in Paropàmiso, accompagnando il lettore in una sorta di grande traversata fra culture differenti – sono di due specie [...]. Ci sono quelli che si svolgono dentro i confini d’una civiltà, e ci sono quelli che ci portano entro i confini di altre civiltà. Quelli che non toccano il muro d’idee e quelli che lo scavalcano'. La catena dello Hindu-Kush – il Paropàmiso attraversato da Alessandro Magno verso il 330 a.C. – ben rappresenta quel muro, separando ma anche mettendo in comunicazione grandi cicli culturali: europeo (attraverso le estreme propaggini della civiltà ellenistica), cinese (Sinkiang, l’antica Serindia), indiano (Kashmir) e islamitico (Azad Kashmir, Pakistan e Afghanistan).
A questo punto vorremmo ricordare due tesi di uno dei nostri filosofi preferiti, il viennese Paul Karl Feyerabend (1924-1994). Per lui il sogno di ridurre il variopinto mosaico delle umane 'forme di vita', se mai si fosse realizzato, sarebbe stato un autentico incubo, perché l’eliminazione della dif-ferenza culturale non coinciderebbe affatto con l’uguaglianza dei diritti, ma con il livellamento e la tirannide. Eppure, possiamo apprezzare la differenza solo se siamo capaci di tramutarci in esploratori disinteressati di ciò che è altro da noi. E questo ci permette di comprendere che alla fine 'ogni cultura è in potenza tutte le culture' (Conquista dell’abbondanza, Raffaello Cortina, Milano 2002). La locuzione in potenza è essenziale, perché dà il senso di una ricerca incessante, che non culmina in una presa di possesso: sotto questo profilo l’esploratore non è mai un conquistatore.
La spedizione del Saraghrar è appunto la consacrazione dell’alpinismo esplorativo, diremmo quasi di una versione fisica dello sforzo intellettuale consigliato da Feyerabend. Nel 1969 ('Rivista Mensile' del Cai, n. 10) Mario Fantin, che aveva partecipato alla spedizione al K2 come fotografo e cineoperatore, ha descritto tale peculiare approccio come un 'tipo di peregrinazione fra i monti e le valli di regioni poco conosciute, e quasi tutti sono d’accordo nel considerarlo alpinismo nel senso più puro [...] dell’espressione'. È anzi un 'tipo di alpinismo così bello, così completo, così vicino alle forme seguite dai nostri progenitori e dai pionieri!'
Tali forme sono squisitamente conoscitive, perché superare i muri delle idee non solo non è meno impegnativo di scalare una parete o di aggirare un ostacolo, ma aumenta il nostro repertorio d’informazione e di espressione. Tornato dal K2, Fantin avrebbe preso parte a non poche spedizioni etnografiche e naturalistiche e nel 1967 sarebbe stato tra i fondatori del Centro Italiano Studio Documentazione Alpinismo Extraeuropeo (CISDAE). E l’impronta del decennio 1954-1963 giunge sino a oggi, poiché il ruolo essenziale dell’alpinismo d’esplorazione è pubblicamente sancito coll’istituzione (1995) da parte del Club Alpino Accademico Italiano di un Riconosci-mento intitolato a uno dei protagonisti dell’ascensione del Saraghrar, Paolo Consiglio; viene assegnato di anno in anno a una spedizione extraeuropea in stile alpino che abbia svolto attività d’indagine eventualmente con finalità scientifiche (per di più 'in sostanziale autonomia da iniziative commerciali') rispettando 'i luoghi attraversati e la montagna salita'"
Potrebbe interessarti anche:

Gestori e rifugi del CAI Torino: il valore di 41000 metri di esperienza
Federica Boggio

Mario Schipani, Luciano Ratto, Mario Bertotto: tre sucaini “storici” ci hanno lasciato nel 2023
Carlo Crovella