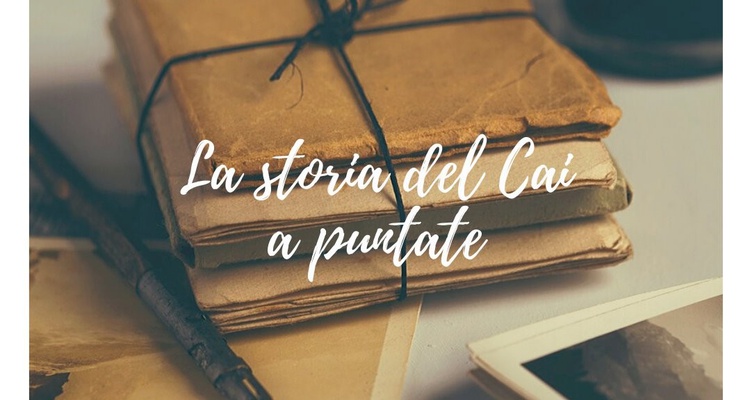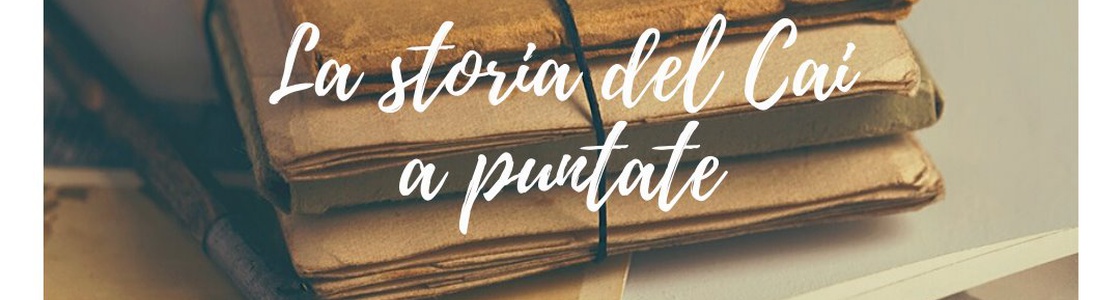

Storia del Cai a puntate, il boom delle sezioni tra il 1874 e il 1883
di Club Alpino Italiano
Secondo articolo del ciclo che si propone di ripercorrere la vita e le trasformazioni del Club alpino italiano. Questa volta è Stefano Morosini a raccontarci la crescita dell'associazione nella seconda metà dell'Ottocento
Secondo appuntamento con la storia del Cai. Questa volta Stefano Morosini racconta il secondo decennio del Club alpino italiano.
"Nei primi anni gli iscritti al Club alpino italiano erano i rappresentanti di un’élite urbana aristocratica e altoborghese, intraprendente e pragmatica, caratterizzata da un forte rigore etico e temprata dalle recenti battaglie risorgimentali. I soci del CAI affermavano gli ideali della nuova Italia tramite la salita di cime inviolate (si veda nell’articolo di Enrico Camanni), ma l’alpinismo pioneristico di questi anni pare ancora lontano dalle successi-ve derive nazionalistiche. A un decennio dalla sua fondazione, il CAI era composto da poco più di 2000 soci, e le sue sezioni andavano diffondendosi rapidamente e in maniera capillare in tutta la penisola, non solo nelle città ai piedi dell’arco alpino.
Significativamente tre sezioni (Torino, 1863; Firenze, 1868; Roma, 1873) nacquero in corrispondenza geografica e temporale con gli spostamenti della capitale d’Italia. Il rapido sviluppo di un così ampio numero di sedi territoriali non pare dettato da una volontà di competizione municipalistica, piuttosto da una forma di emulazione fra diversi contesti urbani, dove la pratica dell’alpinismo è proposta alla cittadinanza (e in particolare alle giovani generazioni) in chiave pedagogica. Attraverso l’iscrizione al Cai ci si poteva sentire parte di una nazione appena nata e praticare l’alpinismo significava esercitare il corpo e il carattere in pioneristiche ascensioni su un terreno, quello alpino, in gran parte inesplorato.
Ancora, i gruppi che nelle varie città diedero vita a sezioni del Cai, lo fecero su basi laiche, anche se in quegli anni non mancarono straordinarie figure di alpinisti-ecclesiastici, come Andrea Zannini ha ben documentato nel volume "Tonache e piccozze". Il clero e la nascita dell’alpinismo. In sintesi gli intenti del Club Alpino Italiano nei suoi primi anni di vita sono al contempo politici, mirando alla prosecuzione del Risorgimento come affermazione dell’Italia unita; geopolitici, mediante l’attestazione nel contesto europeo delle Alpi come frontiera; morali, tramite la contrapposizione fra città malsane e montagna; fisiologici, evidenziando i benefici dell’esercizio fisico in altitudine, come sostenuto dal fisiologo torinese Angelo Mosso (1846-1910); sociali, laddove il costituirsi in associazione è indice di virtù civica; civilizzatori, dato che il CAI operava a sostegno delle popolazioni alpine arretrate economicamente e culturalmente; scientifici, in quanto gli alpinisti, nel corso delle ascensioni, svolgevano misurazioni e classificazioni climatiche, geologiche, faunistiche, botaniche e cartografiche; letterari, essendo ampia la diffusione di racconti e scritti legati alla montagna, la pubblicazione di guide, l’apertura di biblioteche; ambientali, perché sin dalle origini sono presenti istanze di tutela, soprattutto boschiva.
Dal punto di vista istituzionale il CAI ha vissuto una prima fase (1863-1866), in cui è presente una sola sede a Torino, denominata “Club Alpino – Torino”; una seconda (1867-1872), nella quale oltre alla sezione torinese nacquero alcune succursali; una terza (1873-1875) in cui sorsero vere e proprie sezioni, con Torino quale sede centra-le; una quarta (1876-1929), nella quale tutte le sezioni sono poste in condizioni paritetiche e la sede centrale è a Torino, ma quest’ultima ha un proprio consiglio direttivo, separato per componenti e prerogative da quello della sezione della città della Mole. Anche al di fuori dei confini del Regno d’Italia sorsero associazioni alpinistiche vicine per caratteristiche e identità al Cai. La SaT (Società alpina del Trentino è il nome originario) nacque nel settembre del 1872 a Madonna di Campiglio, allora parte dell’Impero austro-ungarico. Attraverso la fondazione della SaT la borghesia liberale trentina si voleva sentire parte del Cai seppur dall’esterno dei confini nazionali: l’attività dei soci denotava un’esplicita missione patriottica e un carattere irredentista: per questa ragione nel 1876 la SAT subì un decreto di scioglimento da parte del governo asburgico, ma prontamente venne ricostituita con l’at-tuale denominazione di Società degli alpinisti tridentini. Una vicenda parallela tra identità nazionale italiana, istanze irredentiste e appartenenza all’Impero austro-ungarico è quella relativa alla Società alpina delle Giulie, costituita a Trieste nel 1883.
Quintino Sella, che fu presidente generale dal 1876 al 1883, morì nel 1884: oltre che alpinista, fondat-re e animatore dei primi decenni di vita del CAI, fu uno straordinario e poliedrico protagonista della stagione politica, economica, culturale e scientifica dell’Italia postunitaria.
Un illustre socio delle Sezione di Napoli, Benedetto Croce, lo ricorderà in questi termini: «avverso all’ascesi cristiana e al disprezzo del corpo, fondò il Club alpino italiano e dette ai suoi connazionali il gusto delle ascensioni, esercizio di volontà, di previdenza, di virtù morale». D’altro canto l’alpinista e intellettuale torinese Gian Piero Motti, nella sua Storia dell’alpinismo, ha definito Sella con ironia tagliente e contestataria: «forse più noto ai più per la poco simpatica fama di spietato gabelliere che per i suoi meriti alpinistici!».
In Italia, diversamente da alcuni altri sodalizi stra-nieri (come il britannico Alpine Club, fondato nel 1857, o il Club alpino svizzero, fondato nel 1863, alcuni mesi prima del CAI) era consentita l’iscrizione femminile: seppur limitatamente, fra gli elenchi degli iscritti alle sezioni, compaiono sin dai primi anni nomi di signore o signorine (quasi sempre mogli, sorelle o figlie di soci).
La contessa Carolina Palazzi-Lavaggi non solo fu iscritta alla sezione di Torino a partire dal 1882, ma fu anche l’autrice della prima ascensione al Moncimour (3167 m), nel gruppo del Gran Paradiso, realizzata nel 1879 insieme al fratello e due amici grazie al fondamentale accompagnamento delle guide alpine. Benché abituata a uno stile di vita agiato, Carolina Palazzi-Lavaggi si adatta con facilità alle «peripezie» e alle scomodità della montagna, non teme i pericoli e fa ricorso alla «picca» quando il ghiaccio affiora sul terreno della salita, durante la quale per ben due volte chiede alle guide di esse-re rassicurata sulla «verginità» del Moncimour, e dunque dalla possibilità che si apre per lei di tocca-re per prima la vetta.
Il linguaggio, come sempre, è denso di significato: Quintino Sella nella sua celebre salita al Monviso aveva parlato della «maschia soddisfazione» che si può provare «nel solcare le meravigliose Alpi» e raggiungerne le più alte cime; e in una lettera ad una gentildonna piemontese, Giuseppina Benso di Cavour, si compiaceva che le giovani figlie della sua corrispondente avessero oltrepassato nelle loro ascensioni i 3300 metri di altitudine, così da «aprire il vergine e sensibile loro animo alle maschie bellezze delle Alpi». Il simboli-smo sessuale del linguaggio è significativo sia della percezione diffusa nell’Italia dell’epoca del forte squilibrio di genere, sia della tendenza ad applicare tale rapporto alle ascensioni in montagna. Ancora più esplicito il lessico utilizzato talora, anche dalla Palazzi-Lavaggi, per definire le prime ascensioni: si parla di «strappare la verginità», di «consumare il banchetto nuziale»".
Potrebbe interessarti anche:
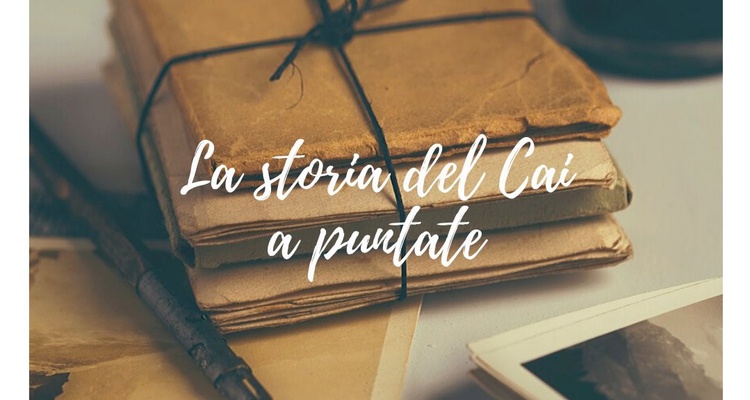
Storia del Cai a puntate, alla scoperta del mondo
Club Alpino Italiano
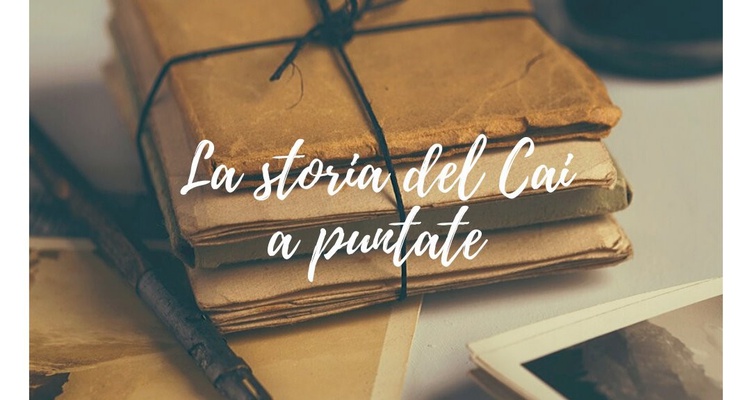
La storia del Cai a puntate, l'alba del Novecento
Club Alpino Italiano